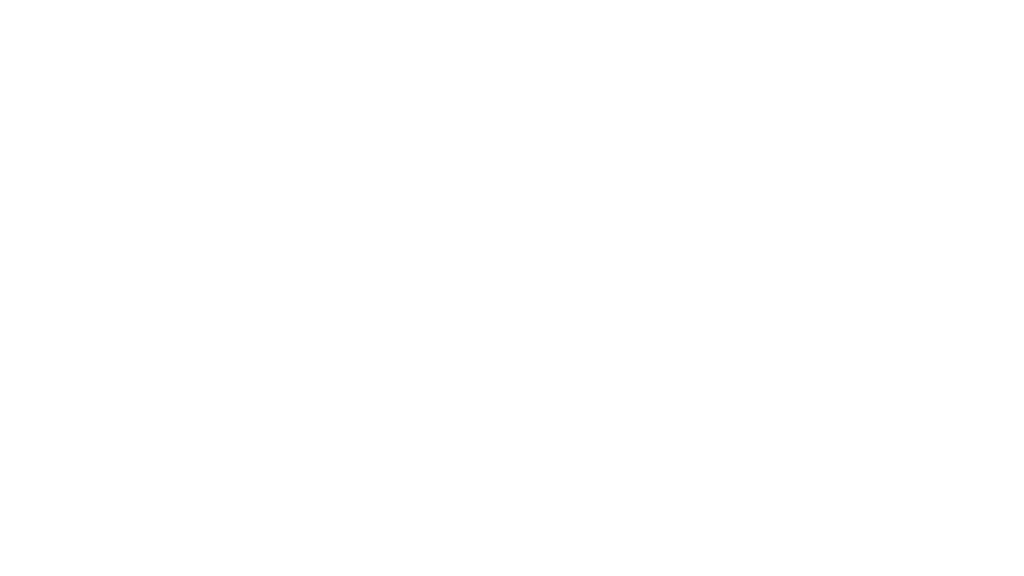Anche senza l’amabile insistenza del mio mecenate Paruccho, oggi mi butto su un nuovo spunto di riflessione sulla storia della nautica antica. Un tema su cui, tra me e il mondo, ci facciamo la stessa domanda da anni:
Ma questi benedetti antichi navigatori… sapevano andare di bolina oppure no?
O, per dirla con parole da circolo velico: riuscivano a risalire il vento a vela, oppure ogni volta che tirava controvento mollavano tutto e giù di remi?
Come al solito, l’argomento è uno di quelli da tesi di laurea (o da sbronza tra marinai) e meriterebbe ben più tempo e spazio di questo. La questione è intricata e le risposte — va detto — tendono a variare a seconda dell’epoca e del popolo preso in esame.
C’è chi la risolve facile: fino alla fine della cosiddetta “età remica” (dal periodo classico fino diciamo all’anno Mille…), se avevi vento in poppa issavi la vela. Se il vento era contro, ti mettevi a remare e tanti saluti. Poi, con l’inizio dell’ “età velica”, le cose si fanno più sofisticate: nuove tecniche permettono alle navi di risalire il vento, anche se con angoli larghissimi — altro che bolina stretta, qui si andava di bolina filosofica!
Ma torniamo al nostro periodo del cuore: l’esordio dell’età remica, il glorioso mondo Classico.
È mai possibile che popoli naviganti come Greci, Fenici, Romani e compagnia bella andassero a vela solo con il vento in poppa, e appena questo girava si buttassero a remare come forsennati?
Un po’ limitante, no? E diciamolo, anche parecchio scomodo.
E qui arriva la chicca. Sì, perché oggi vi porto una vera gemma che non ho mai visto citata nei testi di storia della navigazione. Sto parlando della Meccanica di Aristotele, un’opera minore (tipo il B-side del pensiero aristotelico), in cui il nostro filosofo risponde a 35 domande su fenomeni naturali e su come l’uomo possa sfruttarli a suo vantaggio. Un mix tra fisica, ingegneria e, perché no, nautica.
Nel IV secolo a.C. c’erano già in Grecia scienziati e architetti capaci di costruire templi e calcolare eclissi. Quindi non ci stupisce che Aristotele, una sorta di Piero Angela in tunica, si interessasse un po’ di tutto — anche se, diciamolo, non sempre con competenza da esperto di settore come i suoi contemporanei.
Tra le sue 35 domande, eccone alcune dedicate alla nautica:
«Perché i rematori di centro esercitano una spinta maggiore sulla nave?»
«Perché il timone, pur essendo piccolo e in fondo alla nave, riesce a governare imbarcazioni enormi con la sola forza (modesta) di un uomo?»
«Perché le navi, a parità di velatura e di vento, si muovono più velocemente quanto più alto è il pennone?»
E infine… la nostra domanda preferita:
«Perché, se si vuole navigare prosperamente, anche se le condizioni di vento non sono favorevoli, si imbroglia una parte della vela verso il timoniere e si lasca invece con la scotta l’altra parte, verso prua?»
Traducendo: se si vuole navigare “prosperamente” (cioè arrivare dove si vuole), anche senza vento a favore, i marinai fanno una cosa curiosa: raccolgono (imbrogliano) una parte della vela verso poppa e aprono l’altra verso prua.
E qui Aristotele, forse senza accorgersene, nel formulare il questito, ci dà già la risposta.
Intanto, secondo me, il traduttore (nel mio caso, l’edizione Bompiani) non sapeva distinguere una scotta da una scottatura: la terminologia velica è tutta sbagliata. Ma se leggiamo tra le righe, sembra che i marinai dell’epoca modificassero la forma della vela quadra, stringendola da un lato per farla diventare una sorta di vela triangolare, simile alla futura vela latina. E per di più sembra chiaro che la orientassero per il lungo della nave, una parte rivolta verso prua e una verso poppa.
Altro che scotta lasca: probabilmente erano gli imbrogli (cioè le funi che servono a raccogliere la vela) a essere laschi, mentre la “scotta” — che non è neanche il termine corretto qui — andava cazzata per dare tensione all’inferitura.
Controllando su Wikipedia infatti ritrovo la traduzione della stessa domanda con molto più senso:
«Perché, quando si vuol navigare come se il vento fosse favorevole, ma esso sia invece contrario, si restringe la parte della vela che è verso il timoniere e si spiega invece quella rivolta verso la prora, legandola a orza?»
E come risponde Aristotele a questo quesito? Torna sul suo chiodo fisso: la leva (leitmotiv che si ritrova in tutte e 35 le sue argomentazioni di risposta ai quesiti). E dice:
«Forse il motivo per cui si riducono le vele è che, in presenza di molto vento, il timone non può contrastarne la direzione, cosa che invece è possibile se il vento è poco…»
Insomma, inizia con un bel forse — non esattamente il tono da massimo esperto. Ci dice della pressione sul timone per tenere la barca contro vento, cosa che ovviamente può accadere solo per pochi istanti sfruttando l’abbrivo, non certo si può tenere la rotta in questo modo. Poi ci racconta che, quando il vento rinforza, trasformare la vela non basta e il timone non ce la fa a tenere la rotta. Insomma, se le condizioni sono estreme non rimane che San Gennaro…
E conclude con un’osservazione da applauso:
«Anche i marinai lottano con il vento, gravando con il loro peso dalla parte opposta.»
Geniale! In pratica stanno in falchetta. Fanno sbandare la barca dalla parte opposta al vento (direi sottovento per renderla orziera), come veri regatanti ante litteram.
Morale della favola?
Aristotele aveva visto i marinai fare bolina, aveva sentito qualche spiegazione nell’agorà, ma non aveva capito bene come funzionasse il tutto — e va detto che neppure noi, per secoli, abbiamo compreso la legge fisica che permette alle vele di essere per così dire “aspirate” dal vento, ovvero la portanza. È roba che si è chiarita solo un secolo fa!
Quindi, non è nella risposta, ma nella formulazione stessa della domanda che Aristotele ci lascia un indizio prezioso.
Ed è questo che rende il tutto… beh, semplicemente fantastico.
Marco Filoso